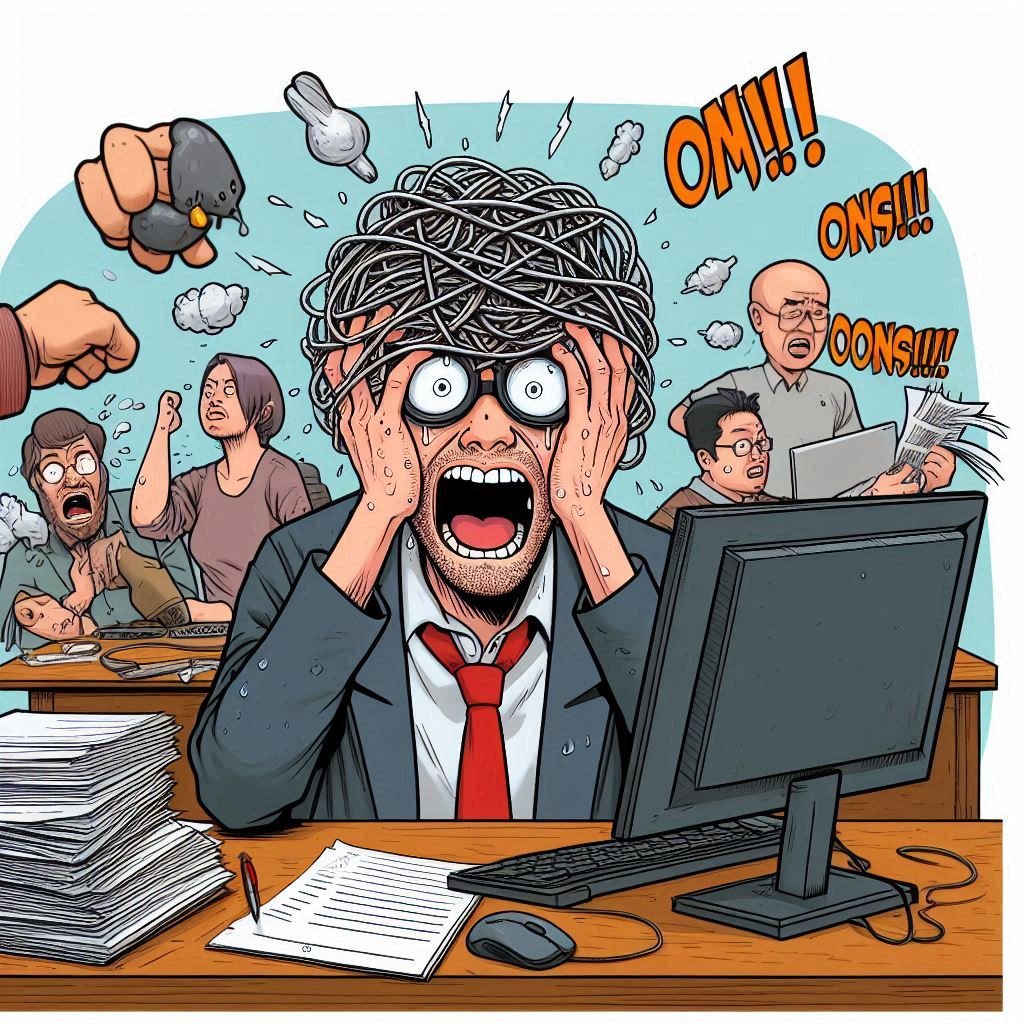La sicurezza sul lavoro non si esaurisce nei dispositivi di protezione individuale, nelle segnaletiche antinfortunio o nei protocolli antincendio. Essa include — e anzi, oggi più che mai richiede — la tutela della salute mentale dei lavoratori. Un ambiente di lavoro tossico, fatto di turni infiniti, umiliazioni davanti ai colleghi, permessi negati senza giustificazione, isolamento sistematico e pressioni continue, non è solo “sgradevole”: è pericoloso. E quando da questo clima nasce ansia cronica, depressione o un disturbo psichico invalidante, la legge riconosce che si tratta di una malattia professionale.
E qui arriva la notizia più importante: l’INAIL deve risarcire.
Anche senza prove di mobbing.
Anche senza fare causa all’azienda.
Il principio della tutela previdenziale oggettiva
Il cuore di questa tutela sta in un principio semplice ma rivoluzionario: non conta l’intenzione di chi ha creato le condizioni dannose, ma il risultato. Non serve dimostrare che il capo “voleva distruggerti”. Basta provare che ti sei ammalato a causa del lavoro.
Questo è il cosiddetto principio della tutela previdenziale oggettiva, affermato per la prima volta in modo inequivocabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988. In essa, la Consulta ha dichiarato incostituzionale qualsiasi limitazione della tutela previdenziale alle sole malattie “tabellate” (cioè elencate in appositi elenchi ministeriali). La salute del lavoratore, infatti, non può dipendere da un elenco burocratico, ma dal nesso causale tra patologia e attività lavorativa.
«La tutela assicurativa deve estendersi a tutte le malattie che, pur non essendo comprese nelle tabelle, siano comunque causate dall’attività lavorativa»
(Corte Costituzionale, sentenza n. 179/1988)
Questo principio è stato poi recepito dal legislatore nel Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), all’articolo 10, comma 4:
«Sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.»
La sentenza di Reggio Emilia: un caso concreto di giustizia
Una recente decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 11 giugno 2025 (causa n. 275/2024 – Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 337) ha applicato con forza questi principi a un caso reale.
Una lavoratrice, impiegata presso un punto vendita nazionale, aveva sviluppato un “severo disturbo d’ansia con depressione, somatizzazioni e sviluppo di fobie, reattivo all’attività lavorativa, scarsamente rispondente ai trattamenti terapeutici”. Aveva denunciato la malattia all’INAIL nel settembre 2022, ma la richiesta era stata rigettata. Dopo aver presentato opposizione amministrativa — rimasta inesplicata — si era rivolta al Giudice del Lavoro.
Il Tribunale, dopo aver svolto istruttoria testimoniale e nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) medico-legale, ha accertato che l’ambiente di lavoro era “gravemente compromesso”, soprattutto a causa di due figure apicali che impartivano ordini “in modo irridente e offensivo”, creando un clima di continua pressione e umiliazione.
Ebbene: il giudice ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto un’invalidità parziale e ha condannato l’ente previdenziale a corrispondere le prestazioni dovute.
Nella motivazione, il Tribunale ha ribadito un punto cruciale:
«Non è necessaria, ai fini della tutela sociale, la prova dell’intento persecutorio da parte del soggetto, o dei soggetti, che hanno posto in essere dette condizioni.»
In altre parole: non serve il mobbing. Basta il nesso causale tra clima lavorativo e patologia psichica.
Malattie non tabellate? Sì, ma con prova del nesso
I disturbi psichici da stress non sono inclusi nelle tabelle ministeriali delle malattie professionali. Tuttavia, come chiarito sia dalla Corte Costituzionale che dal D.Lgs. 38/2000, ciò non esclude la tutela. L’importante è che una perizia medico-legale (come quella del CTU nel caso di Reggio Emilia) accerti che ansia, depressione o PTSD derivino direttamente dalle condizioni di lavoro.
Se ciò avviene, l’INAIL è obbligato a intervenire: con indennità, rendita, cure e, nei casi più gravi, con il riconoscimento di un’invalidità permanente.
Tempi e termini: quando e come agire
Ottenere questa tutela richiede il rispetto di precisi termini di legge.
- Denuncia all’INAIL: deve essere presentata entro 15 giorni dalla:
- data di cessazione dell’attività lavorativa che ha causato la malattia, oppure
- data di manifestazione dei primi sintomi invalidanti (art. 49, D.Lgs. 38/2000).
- Opposizione amministrativa: in caso di rigetto, il lavoratore può presentare opposizione entro 3 anni dalla data del provvedimento di diniego (art. 50).
- Ricorso al Giudice del Lavoro: se l’opposizione non viene esaminata entro 180 giorni, il lavoratore può ricorrere in tribunale.
- Prescrizione: l’azione per ottenere le prestazioni INAIL si prescrive in 3 anni. Il termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto (o avrebbe dovuto avere) conoscenza del nesso tra malattia e lavoro (Cass. SS.UU. n. 26880/2020).
Importante: la tempestiva denuncia all’INAIL interrompe la prescrizione, consentendo di agire anche a distanza di anni, purché il percorso amministrativo sia stato avviato correttamente.
Un messaggio chiaro per tutti i lavoratori
Questa sentenza — e il sistema giuridico che la sostiene — lancia un messaggio inequivocabile:
la dignità è una forma di sicurezza.
Non sei “solo stressato”. Se il tuo posto di lavoro ti logora l’anima fino a farti ammalare, hai diritto alla tutela. Non devi dimostrare cattiveria, persecuzione o cospirazione. Devi solo dimostrare — con l’aiuto di medici, psicologi e avvocati — che il lavoro ti ha fatto ammalare.
E in quel caso, l’INAIL paga. Perché la Costituzione, la legge e i giudici lo hanno stabilito: la salute mentale è salute. E la salute è un diritto.