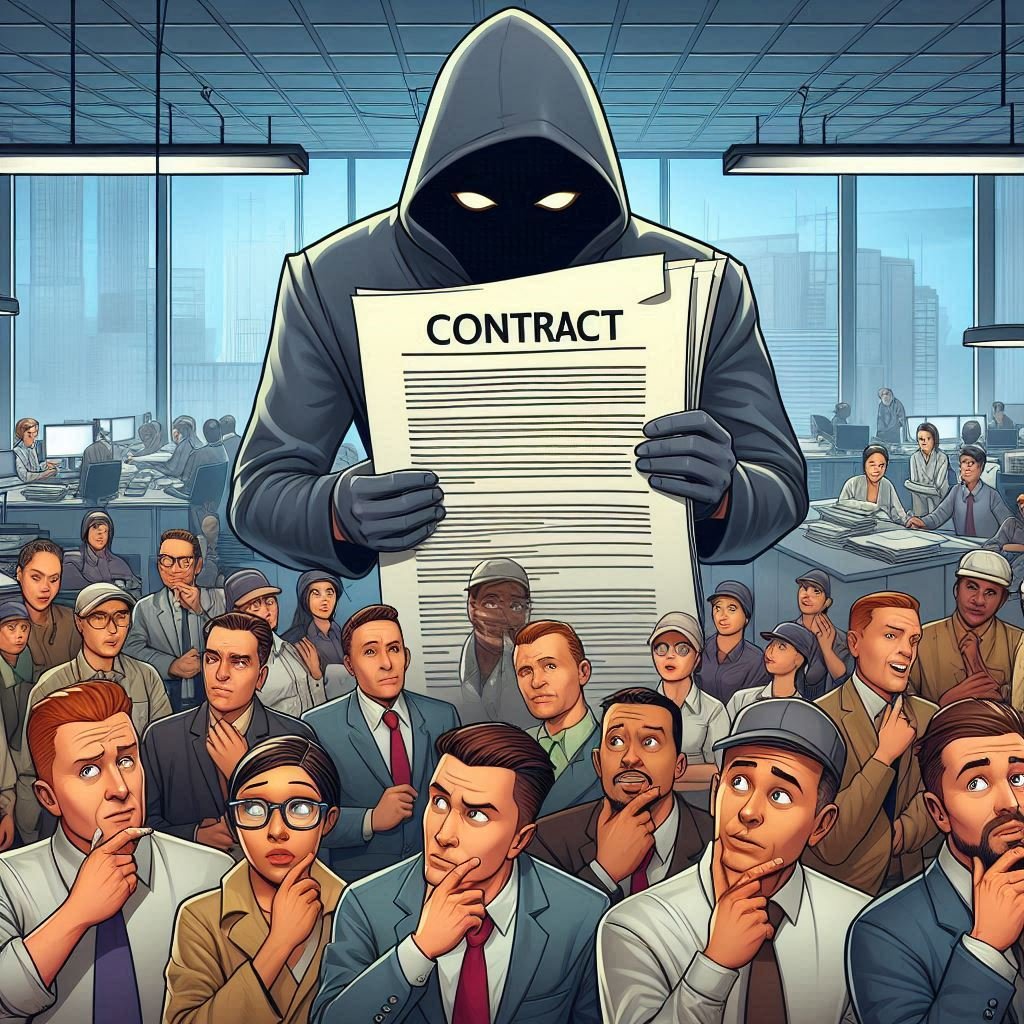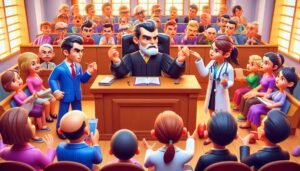In un recente ricorso in appello, una giovane lavoratrice ha chiesto al giudice di riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato diretto con la società committente, nonostante fosse formalmente assunta da una cooperativa terza. Il caso solleva questioni cruciali sulle dinamiche dell’outsourcing nel settore logistico e sulla corretta applicazione della normativa anti-interposizione.
I fatti
La lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo determinato da una società terza, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato con qualifica di autotrasportatore. Tuttavia, fin dall’inizio, la sua attività si è svolta esclusivamente presso un centro logistico gestito dalla committente, senza alcuna presenza continuativa di referenti della società che l’aveva formalmente assunta.
Indossava una divisa con il logo della committente, utilizzava un palmare intestato alla stessa per gestire consegne, documenti di trasporto e comunicazioni con i clienti, e riceveva istruzioni operative quotidiane direttamente dai dipendenti della committente. Inoltre, svolgeva regolarmente mansioni di magazzino — compiti non previsti dal suo contratto originario — e in caso di malattia era tenuta ad avvisare direttamente la committente, la quale provvedeva poi a informare la società terza.
Nel 2024, al termine del rapporto tra la committente e la società terza, tutti i colleghi sono stati ricollocati in altre cooperative affiliate, tranne lei, che è rimasta formalmente dipendente ma senza percepire retribuzione per tre mesi consecutivi.
La questione giuridica
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo legittimo il contratto tra le due società e negando qualsiasi forma di interposizione illecita. Tuttavia, nel ricorso in appello si contesta questa conclusione, sostenendo che il rapporto andava qualificato come appalto illecito ex art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, poiché mancavano i requisiti sostanziali di autonomia organizzativa, potere direttivo effettivo e assunzione del rischio d’impresa da parte della società appaltatrice.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3768/2022):
“Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. ‘labour intensive’), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa.”
Nel caso in esame, nessuno di questi elementi era presente: la pianificazione delle consegne, gli orari, le zone di competenza, il monitoraggio in tempo reale e persino le sanzioni disciplinari informali erano gestiti direttamente dalla committente. La società terza si limitava a compiti meramente amministrativi, come la corresponsione dello stipendio e la gestione delle ferie — circostanze che, stando alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 16153/2025), non sono sufficienti a qualificare come genuino un appalto di servizi.
Discriminazione e danno patrimoniale
Particolarmente rilevante è anche la circostanza che la lavoratrice non sia stata ricollocata, a differenza di tutti gli altri colleghi. Tale condotta, unita alla mancata retribuzione per mesi, configura — secondo la difesa — un trattamento discriminatorio e ritorsivo, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 7, L. n. 300/1970. La Corte di Cassazione (n. 11137/2024) ha infatti affermato che:
“La mancata ricollocazione di un lavoratore, a fronte della ricollocazione sistematica di tutti gli altri colleghi, configura un comportamento discriminatorio suscettibile di risarcimento.”
Qualificazione del contratto: non basta la denominazione
Infine, il Tribunale aveva erroneamente qualificato il rapporto tra le due società come “contratto di trasporto”, ignorando la natura continuativa, sistematica e integrata delle prestazioni rese. Ma, come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 15227/2016):
“La qualificazione del rapporto negoziale non può fondarsi sulla mera denominazione attribuitagli dalle parti, ma deve essere desunta dall’effettivo contenuto delle prestazioni pattuite e dalla concreta modalità di esecuzione.”
In contesti labour-intensive come quello logistico, dove l’attività si svolge con carattere di continuità e sotto il pieno controllo operativo del committente, il contratto va correttamente qualificato come appalto di servizi, e non come trasporto occasionale.
Conclusioni
Questo caso rappresenta un classico esempio di come forme contrattuali apparentemente legittime possano nascondere relazioni di lavoro subordinato mascherate. La giurisprudenza è chiara: la sostanza prevale sulla forma. Quando una società terza non esercita alcun potere organizzativo né assume rischi imprenditoriali, ma si limita a “prestare” manodopera sotto il pieno controllo di un’altra impresa, si configura un’appalto illecito con conseguente responsabilità solidale del committente come datore di lavoro occulto.
Per i professionisti del diritto del lavoro, ma anche per le aziende che ricorrono all’outsourcing, il messaggio è inequivocabile: l’autonomia organizzativa dell’appaltatore non è un optional, ma un pilastro essenziale per evitare gravi conseguenze legali e risarcitorie.