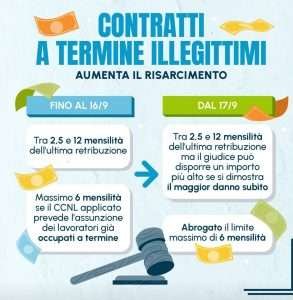Nel panorama del diritto di famiglia italiano, pochi temi generano tanta incertezza — e contenzioso — quanto il mantenimento dei figli maggiorenni. A lungo considerato un diritto quasi illimitato nel tempo, soprattutto in una società in cui i giovani faticano a emanciparsi economicamente, questo istituto è stato progressivamente ridisegnato dalla giurisprudenza per rispondere a un’esigenza di equilibrio: da un lato, proteggere chi non può ancora mantenersi; dall’altro, evitare forme di dipendenza prolungata che ostacolano la crescita personale e gravano ingiustamente sui genitori.
È in questo contesto che si inserisce una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione — Sezione I civile, ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25535 — che chiarisce in modo netto: l’inserimento del figlio nel mondo del lavoro determina la cessazione dell’obbligo di mantenimento e, di conseguenza, la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Il caso: un padre, un figlio e una casa che non è più “familiare”
La vicenda riguardava un padre separato cui era stata assegnata la casa coniugale in quanto genitore convivente con il figlio, ormai maggiorenne. L’assegnazione era stata disposta in base all’articolo 337-sexies del codice civile, che consente di destinare l’abitazione alla famiglia del genitore con cui i figli abitualmente risiedono, purché sussista un’esigenza di tutela — anche per figli non più minori, ma non ancora economicamente indipendenti.
Tuttavia, col tempo il figlio aveva iniziato a lavorare, acquisendo una fonte di reddito autonoma. A quel punto, l’altro genitore aveva chiesto la revoca dell’assegnazione, sostenendo che i presupposti per il mantenimento erano venuti meno. Il Tribunale aveva accolto la richiesta, e sia il padre che il figlio avevano proposto reclamo, lamentando la precarietà del lavoro e la mancanza di una reale autonomia economica.
La Corte d’Appello aveva rigettato i reclami, e la Cassazione ha ora confermato tale decisione con un’ordinanza chiara e stringente.
Il principio: il mantenimento non è eterno
La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato, ma spesso frainteso: l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma perdura finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica. Tuttavia — ed è qui la novità più rilevante — una volta acquisita tale indipendenza, anche solo in via potenziale o parziale, l’obbligo di mantenimento si estingue.
Ciò significa che l’avvio di un’attività lavorativa, anche se non stabile o ben retribuita, costituisce un fatto sufficiente a far decadere il diritto al mantenimento, a meno che non si dimostri che il reddito è del tutto inidoneo a garantire un sostentamento minimo. Ma soprattutto — e questo è il passaggio più incisivo — eventuali difficoltà successive (come un licenziamento, una crisi temporanea o la scelta di abbandonare il lavoro per riprendere gli studi) non riattivano l’obbligo di mantenimento.
In tali casi, al massimo può sorgere un obbligo alimentare ex articolo 433 del codice civile, ben più limitato e subordinato a condizioni rigorose: lo stato di bisogno effettivo, l’impossibilità di provvedere a sé stessi e la mancanza di altre fonti di sostegno.
La casa familiare: un diritto legato al bisogno, non alla convivenza
L’ordinanza affronta anche un aspetto spesso trascurato: l’assegnazione della casa coniugale non è un diritto del genitore, né una forma di indennizzo per la separazione. È uno strumento di tutela del figlio, finalizzato a garantirgli stabilità abitativa finché ne ha effettivo bisogno.
Pertanto, una volta che il figlio diventa economicamente autonomo, anche solo parzialmente, viene meno il presupposto stesso dell’assegnazione. Il genitore non può più trattenere l’abitazione “per il figlio” se questi non ne ha più necessità ai fini del mantenimento. Questo principio, già presente negli articoli 337-sexies e 337-septies del codice civile, viene ora applicato con rigore dalla Cassazione, segnando un cambio di passo rispetto a interpretazioni più indulgenti del passato.
Un segnale culturale oltre che giuridico
Dietro questa decisione c’è anche un messaggio culturale: la società e il diritto non possono — né devono — sostenere indefinitamente chi ha già avuto l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro. L’obiettivo del mantenimento non è creare una rete di sicurezza permanente, ma accompagnare il passaggio all’età adulta. Una volta compiuto quel passo, anche in modo imperfetto, il sistema giuridico considera conclusa la fase di sostegno ordinario.
Questo non significa negare ai giovani il tempo necessario per costruirsi un futuro. Significa, però, distinguere tra difficoltà transitorie e mancanza di autonomia reale, e evitare che il diritto di famiglia diventi un surrogato delle politiche sociali.
Conclusioni operative
Per avvocati, giudici e famiglie, questa ordinanza offre un criterio oggettivo per valutare la sussistenza del mantenimento: l’effettivo inserimento nel mercato del lavoro, anche con contratti atipici, è un elemento decisivo. Allo stesso tempo, ricorda che l’assegnazione della casa familiare è funzionale al mantenimento del figlio, non a garantire un vantaggio abitativo permanente a un genitore.
In un’epoca in cui i tempi di transizione all’età adulta si allungano, la giurisprudenza sembra voler tracciare un confine più netto: il diritto al sostegno dei genitori non è illimitato, e l’autonomia — anche parziale — ha un valore giuridico rilevante.