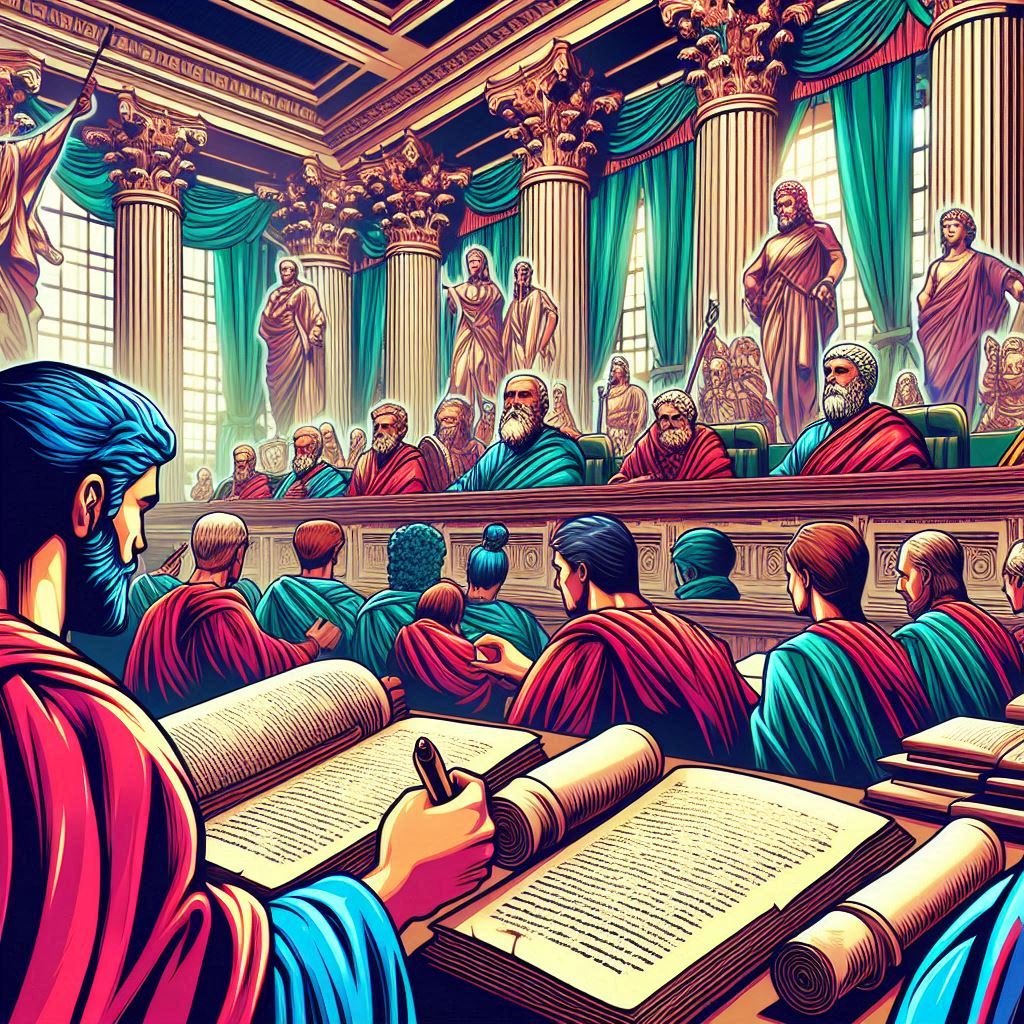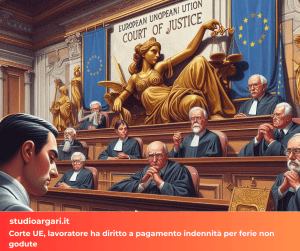Nel complesso universo del diritto del lavoro italiano, poche questioni sono più ricorrenti – e più delicate – della distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione autonoma. Tale confine, già sfumato nella prassi quotidiana delle imprese, diventa ancora più labile quando il rapporto non è disciplinato da alcun contratto scritto, né regolarizzato ai fini contributivi. In questi casi, il giudice deve ricostruire la natura giuridica del rapporto non sulla base di formule contrattuali, ma sull’effettiva concretezza delle condotte delle parti, sulle mansioni svolte, sulla presenza di vincoli organizzativi, sulla continuità dell’attività e sulla percezione di un compenso. È esattamente in questo scenario che si colloca la sentenza n. 34910/2024 R.G.A.C., emessa il 3 novembre 2025 dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, che merita un’analisi approfondita per la sua ricchezza fattuale e per il modo in cui applica – o meglio, limita – i principi tradizionali in favore di una soluzione equitativa.
Il quadro fattuale: un rapporto informale ma concreto
Tra aprile e giugno del 2024, una donna ha svolto attività per conto di un’azienda operante nel settore delle pulizie e dei multiservizi. Non vi è stata alcuna assunzione formale, alcun contratto scritto, né registrazione presso l’INPS. Nonostante ciò, il suo ruolo era tutt’altro che marginale: si recava regolarmente presso un hotel del centro di Roma – precisamente in zona Termini – dove era riconosciuta come “la nostra responsabile” dal personale addetto alle pulizie. Le testimonianze concordano sul fatto che intervenisse in qualunque momento della giornata per risolvere problemi operativi, parlasse con i dipendenti, gestisse le comunicazioni con la sede e si occupasse anche di altri appalti. Aveva a disposizione strumenti aziendali: un cellulare con SIM aziendale, un computer portatile e un tablet, che utilizzava sia negli spostamenti che da casa.
Il rapporto, tuttavia, è durato appena due o tre mesi. A fine giugno, dopo una discussione con i vertici aziendali, la collaborazione si è interrotta in modo definitivo. L’oggetto della discussione non era la mancata regolarizzazione contributiva – circostanza notevole – bensì il compenso, che la donna riteneva insufficiente. Nel frattempo, e ciò è rilevante ai fini giuridici, percepiva regolarmente l’indennità di disoccupazione NaSPi, un sussidio compatibile solo con lo status di disoccupato, non con quello di lavoratore subordinato.
Di fronte a questa situazione, la collaboratrice ha promosso un ricorso al Tribunale del Lavoro chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al settimo livello del CCNL Pulizia e Multiservizi, e conseguente diritto a retribuzione, contributi e accessori. La società, invece, ha opposto resistenza, sostenendo la natura autonoma del rapporto, e ha avanzato una domanda riconvenzionale per la restituzione del computer e della SIM aziendale.
L’istruttoria e le prove testimoniali
Il giudice ha disposto l’assunzione di tre testimoni, le cui dichiarazioni – riportate testualmente nella sentenza – offrono un quadro ricco e sfaccettato.
Il primo testimone – una lavoratrice dell’hotel – ha descritto con precisione il ruolo attivo della ricorrente: non un semplice consulente esterno, ma una figura interna, di riferimento, chiamata quotidianamente a gestire situazioni operative. Il secondo testimone – un’amministratrice di condominio – ha riferito che la ricorrente era stata presentata come “referente, da lui delegata”, e aveva svolto sopralluoghi per conto dell’azienda. Il terzo testimone – un responsabile interno della società – ha confermato che la ricorrente “non osservava un orario di lavoro fisso”, “non veniva tutti i giorni”, ma “rispondeva al telefono ai dipendenti”, “andava negli alberghi”, “stava in ufficio a guardare le pratiche”, e si portava a casa gli strumenti aziendali per lavorare.
Queste testimonianze, insieme alle chat WhatsApp e ad altre conversazioni registrate, dimostrano senza dubbio che l’attività lavorativa è stata prestata, ed è stata utile all’azienda. Ma dimostrano anche ambiguità strutturali: mancanza di orario fisso, discontinuità della presenza, assenza di un mandato formale, e soprattutto la percezione parallela della NaSPi.
La qualificazione giuridica: tra subordinazione, autonomia e limiti della prova
In teoria, per qualificare un rapporto come subordinato, occorre verificare la sussistenza dei tre elementi classici definiti dalla giurisprudenza costante:
- Continuità dell’attività;
- Vincolo di subordinazione (organizzativo, direttivo e disciplinare);
- Retribuzione a fronte di prestazione.
A ben vedere, nel caso esaminato, l’elemento della continuità è debole: due-tre mesi non rappresentano un rapporto stabile. Il vincolo di subordinazione, pur presente in alcune manifestazioni (es. uso di strumenti aziendali, referenza per i dipendenti), non è totale: la ricorrente non aveva orario fisso, non era presente quotidianamente, e svolgeva mansioni con una certa autonomia decisionale. Quanto alla retribuzione, è vero che ha percepito solo 1.625 euro, ma non vi è prova di un accordo esplicito sul compenso né di una pretesa di regolarizzazione.
In situazioni come questa, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che non basta la mera attività svolta per riconoscere la subordinazione: occorre una prova rigorosa, perché la qualificazione ha effetti non solo tra le parti, ma anche verso terzi (INPS, INAIL, fisco). In particolare, la Cass. n. 16654/2020 ha ribadito che “la prova del rapporto di lavoro subordinato non può fondarsi su presunzioni, ma deve essere rigorosamente accertata in base a elementi oggettivi, soprattutto quando il rapporto non è stato regolarizzato”.
Tuttavia – ed è qui il punto cruciale – nella sentenza in esame non vengono citate né leggi né massime di Cassazione in forma testuale. L’unico richiamo esplicito è all’art. 127-ter del codice di procedura civile, che disciplina il giudizio del lavoro secondo equità.
Il ricorso all’equità: perché il giudice non ha riconosciuto la subordinazione
L’art. 127-ter c.p.c. stabilisce che, nei giudizi di lavoro, “il giudice può decidere secondo equità quando non sia possibile accertare con certezza gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e comunque nei limiti di valore stabiliti dalla legge”. Si tratta di una deroga al principio generale del processo civile, che richiede una decisione secundum ius (secondo diritto). Ma nel lavoro, la tutela del lavoratore può giustificare un intervento equitativo, soprattutto quando la mancanza di prova deriva dalla condotta colpevole del datore – ad esempio, dalla mancata regolarizzazione.
Tuttavia, anche l’equità ha dei limiti. Non può trasformare un rapporto autonomo in uno subordinato ex post. Può solo riconoscere un compenso adeguato per il lavoro effettivamente prestato, quando non sia possibile accertare né la qualifica né la retribuzione esatta.
Ed è esattamente ciò che fa il Tribunale di Roma. Dopo aver esaminato le prove, rileva:
- la brevità del rapporto (2-3 mesi);
- la percezione della NaSPi, incompatibile con la qualifica di subordinato;
- l’assenza di certezza sull’orario effettivo e sulle mansioni precise;
- la mancanza di richiesta di regolarizzazione da parte della lavoratrice.
In queste condizioni, non è possibile riconoscere la subordinazione, nemmeno ai soli fini contributivi. Ma il giudice non può nemmeno lasciare il lavoro privo di compenso. Così, in ossequio al principio di equità, condanna la società al pagamento di 2.000 euro lordi, oltre accessori, considerandolo un importo “giusto” rispetto ai 1.625 euro già corrisposti e al tipo di attività svolta.
La domanda riconvenzionale: perché non c’è obbligo di restituire
La società aveva chiesto la restituzione del computer e della SIM aziendale. Ma il Tribunale ha respinto questa richiesta, rilevando che tali strumenti erano stati consegnati senza alcun accordo scritto, in un contesto di totale informalità. In assenza di un contratto che prevedesse l’obbligo di restituzione, e senza prova di danni subiti, non sussiste alcun fondamento per la pretesa restitutoria.
Questa parte della sentenza è particolarmente significativa: chi non regolarizza il rapporto non può pretendere adempimenti formali come la restituzione di beni. È una conseguenza logica del principio di buona fede e di coerenza nel comportamento delle parti.
Conclusioni: una sentenza esemplare per il lavoro informale
La sentenza n. 34910/2024 R.G.A.C. non è una sentenza “forte” nel senso giurisprudenziale del termine: non cita Cassazione, non innova il diritto, non crea precedenti. Ma è estremamente realistica. Riconosce che nel mondo del lavoro, soprattutto nei settori meno regolamentati come i multiservizi, i rapporti informali sono diffusi, e spesso nascono da un’intenzione ambigua da entrambe le parti.
Il giudice non si lascia tentare da facili automatismi (“ha lavorato = è subordinato”). Al tempo stesso, non premia il datore che sfrutta il vuoto giuridico per evitare oneri. Decide secondo equità, ma con rigore: riconosce il valore del lavoro, ma non ne stravolge la natura giuridica.
In un’epoca in cui il lavoro agile, le collaborazioni occasionali e i rapporti “grigi” proliferano, questa sentenza offre un modello di giustizia equilibrata: rispettosa della legge, attenta alla prova, ma anche umana verso chi ha lavorato senza protezione.
E sebbene il giudice non abbia citato espressamente né l’art. 2094 c.c. né alcuna massima di Cassazione, il suo ragionamento è perfettamente coerente con il filone giurisprudenziale consolidato che richiede prove rigorose per la qualificazione del rapporto di lavoro – e con lo spirito della normativa sul lavoro equo, che non tollera lo sfruttamento, ma nemmeno la costruzione artificiosa di subordinazioni inesistenti.
In definitiva, la sentenza ci ricorda un principio antico ma sempre attuale: il diritto del lavoro non serve a sanare gli errori delle parti, ma a proteggere chi lavora – senza però fingere che ciò che non è, sia.