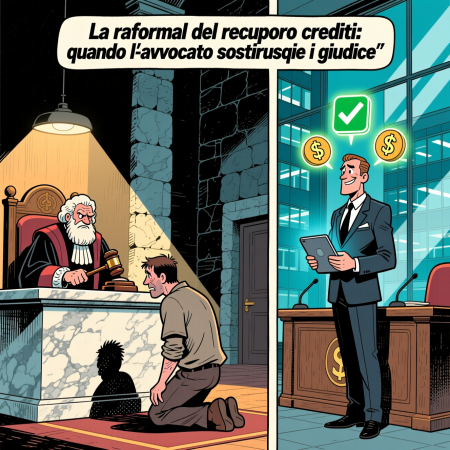Analisi critica alla luce del Ddl 978 e della riforma dell’esecuzione forzata
Negli ultimi mesi, il dibattito giuridico italiano si è concentrato su una riforma destinata a modificare radicalmente il volto del recupero crediti: il disegno di legge 978, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, introduce infatti una procedura che affida direttamente all’avvocato del creditore il potere di emettere un’intimazione ad adempiere, la quale, in assenza di opposizione da parte del debitore entro 40 giorni, diventa automaticamente titolo esecutivo, al pari di una sentenza. Si tratta, secondo molti osservatori, di una “rivoluzione copernicana” nel campo del recupero crediti, con effetti potenzialmente rilevanti sul piano sociale e sulla tutela dei diritti fondamentali, a cominciare dal diritto di difesa.
Attualmente, il sistema vigente prevede il cosiddetto procedimento monitorio: il creditore, tramite il proprio legale, presenta un ricorso a un giudice civile (onorario o togato), il quale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 633 del codice di procedura civile, come la presenza di prove scritte del credito. Solo dopo questa verifica il magistrato emette il decreto ingiuntivo, un ordine di pagamento formale notificato al debitore. Questo controllo preventivo, pur essendo spesso di natura meramente documentale, rappresenta una garanzia fondamentale di terzietà, poiché a decidere sulla fondatezza della pretesa creditizia non è una parte del processo, ma un’autorità imparziale.
Il Ddl 978 scardina questo impianto. La riforma elimina il passaggio obbligatorio davanti al giudice e affida all’avvocato del creditore il potere di notificare un’intimazione ad adempiere che, se non contestata entro quaranta giorni, acquista efficacia esecutiva. In pratica, diventa un titolo valido per avviare pignoramenti e altre azioni di recupero forzato, senza che un giudice abbia mai esaminato preventivamente la fondatezza della pretesa. L’obiettivo dichiarato è accelerare le procedure e ridurre il carico di lavoro dei tribunali, ma le implicazioni sono profonde: si trasferisce di fatto una funzione tipicamente giurisdizionale nelle mani di un legale di parte.
Questa novità ha sollevato forti perplessità, soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori. Antonio Tanza, presidente di Adusbef (Associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari), ha evidenziato i rischi connessi a questa riforma. “Il primo profilo è comunicativo-garantistico”, spiega Tanza. Un atto così incisivo, proveniente da un avvocato e redatto con un linguaggio tecnico simile a quello di un provvedimento giudiziario, “rischia di generare nel destinatario l’apparenza di un provvedimento dell’autorità”. Questa confusione, secondo l’associazione, potrebbe indurre il debitore a pagare anche quando il credito è contestabile, per timore di conseguenze immediate, precludendo di fatto il suo diritto di difesa.
Per evitare una deriva che schiacci i diritti dei soggetti più deboli, Adusbef avanza una serie di proposte correttive. Si chiede di agire sulla forma dell’atto di intimazione, prevedendo un frontespizio obbligatorio scritto in “linguaggio piano e ben visibile” che chiarisca in modo inequivocabile che non si tratta di un atto del giudice e che il destinatario ha quaranta giorni per opporsi. Tra le altre garanzie richieste vi sono: l’indicazione obbligatoria del foro competente del debitore, l’allegazione di un “pacchetto informativo” con una guida ai possibili rimedi e riferimenti a sportelli di assistenza, e infine l’introduzione di una “valvola” di sicurezza, ovvero una possibilità di opposizione tardiva per far valere, ad esempio, la presenza di clausole abusive o pratiche commerciali scorrette, con sospensione automatica dell’esecuzione. Queste misure sono pensate per trasformare un atto percepito come una minaccia in uno strumento di informazione trasparente e per riequilibrare una procedura che, altrimenti, rischia di favorire in modo sproporzionato la parte creditrice.
Parallelamente, un’altra riforma sta prendendo forma nel campo dell’esecuzione forzata, come illustrato nell’articolo di Giuseppe Miccolis pubblicato su Questioni di Giustizia, intitolato “L’esecuzione forzata nella riforma che ci attende”. Il disegno di legge delega predisposto dall’ufficio legislativo del Ministero della giustizia – già approvato dal Senato e ora all’esame della Camera – interviene sull’esecuzione forzata con modifiche correttive e di assestamento, piuttosto che con interventi epocali, salvo per la vendita diretta. L’obiettivo generale resta il “fattore tempo”, in linea con le indicazioni del PNRR, ma con un approccio più pragmatico rispetto alle riforme del processo di cognizione.
Il ddl delega, all’articolo 10, prevede una serie di interventi mirati:
- l’abolizione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva, ritenendo sufficiente la sola attestazione di conformità all’originale;
- la sospensione del termine di efficacia del precetto sino alla conclusione della ricerca telematica dei beni del debitore;
- l’anticipazione del termine per il deposito delle certificazioni ipocatastali, parificandolo a quello per proporre l’istanza di vendita;
- la collaborazione tra custode e esperto per il controllo della documentazione di cui all’art. 567 cpc;
- la nomina anticipata del custode giudiziario entro 15 giorni dal deposito dei documenti;
- la liberazione dell’immobile non abitato dal debitore al più tardi al momento dell’autorizzazione alla vendita, e di quello abitato solo al momento dell’aggiudicazione, salvo attività ostruzionistiche;
- l’introduzione di schemi standardizzati per la relazione di stima e gli avvisi di vendita;
- l’obbligo per il custode di attuare la liberazione dell’immobile in favore dell’aggiudicatario o assegnatario;
- la fissazione del termine di un anno per la delega delle operazioni di vendita, con obbligo di almeno tre tentativi e sostituzione del professionista in caso di inadempienza;
- il termine di venti giorni per proporre reclamo avverso gli atti del professionista, con assoggettamento del provvedimento conseguente all’opposizione agli atti;
- la disciplina specifica per l’affidamento in via esclusiva al professionista del progetto di distribuzione;
- la vendita immobiliare privata, ispirata al modello francese della vente privée;
- l’estensione delle norme antiriciclaggio alle operazioni di vendita in procedure esecutive;
- l’istituzione presso il Ministero della giustizia di banche dati per il monitoraggio dell’applicazione della normativa antiriciclaggio.
Tra queste, la vendita privata rappresenta una novità significativa: il debitore potrà chiedere al giudice dell’esecuzione, entro dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 569 cpc, di essere autorizzato a vendere privatamente il bene pignorato, purché il prezzo sia almeno pari al valore di stima, l’istanza sia corredata da una proposta irrevocabile di acquisto e sia prestata una cauzione pari almeno al 10% del prezzo proposto. L’operazione deve essere pubblicizzata adeguatamente per consentire offerte concorrenti, e si procede come per la vendita senza incanto, con termini più ridotti. L’istanza può essere proposta una sola volta.
Inoltre, il ddl introduce la possibilità che la misura coercitiva indiretta (art. 614-bis cpc) possa essere applicata anche dal giudice dell’esecuzione, non solo da quello della cognizione, e prevede criteri per la determinazione dell’ammontare e del termine di durata di tale misura, cercando di ridurre la discrezionalità attualmente totale del giudice.
Parallelamente, alcune modifiche sono introdotte direttamente dal legislatore, senza delega al governo. Tra queste, spicca la modifica della competenza nell’espropriazione presso terzi in danno di una pubblica amministrazione: sarà competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Inoltre, viene introdotto l’obbligo, a pena di inefficacia del pignoramento, di notificare al debitore e al terzo l’avvenuta iscrizione a ruolo, nonché di depositare l’avviso notificato nel fascicolo.
In conclusione, mentre il ddl 978 punta a semplificare drasticamente il recupero crediti, affidando all’avvocato un ruolo quasi giurisdizionale, la riforma dell’esecuzione forzata cerca di ottimizzare una disciplina già ben strutturata, intervenendo su aspetti tecnici e procedurali per migliorare efficienza e trasparenza. Tuttavia, la prima riforma solleva interrogativi di rilievo costituzionale, soprattutto in relazione al diritto di difesa e alla terzietà del giudice, mentre la seconda appare più equilibrata e pragmatica. Resta da vedere se il legislatore saprà trovare un punto di equilibrio tra efficienza e garanzie, senza sacrificare i diritti dei più deboli sull’altare della velocità.