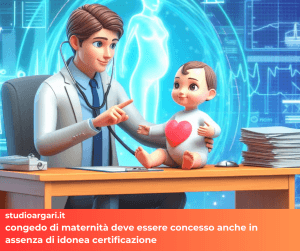Introduzione
Il 2025 si chiude con due novità legislative apparentemente complementari, ma in realtà profondamente distinte per portata e concretezza: da un lato, la Legge 106 del 2025, che riforma e amplia le tutele per i lavoratori fragili e introduce per la prima volta un congedo strutturato per autonomi e professionisti; dall’altro, il fondo caregiver nella Legge di Bilancio 2026, che promette una riforma organica del ruolo di cura familiare, ma con risorse iniziali irrisorie. Analizziamo entrambe le normative alla luce del diritto vigente, della giurisprudenza recente e delle criticità ancora irrisolte.
La Legge 106/2025: nuove tutele per lavoratori dipendenti e autonomi
La Legge 106 del 2025 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2025) non sostituisce la storica Legge 104/1992, ma ne rafforza il perimetro di applicazione, introducendo strumenti di protezione più articolati per chi vive condizioni di fragilità personale o assiste familiari con disabilità grave.
Per i lavoratori dipendenti, la norma prevede:
- 10 ore aggiuntive annue di permesso retribuito, da affiancare ai canonici 3 giorni mensili già previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992. Queste ore sono destinate a visite, esami e terapie urgenti per sé o per un familiare con invalidità ≥ 74%.
- Un congedo straordinario fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con garanzia di conservazione del posto di lavoro (art. 4, co. 1, Legge 106/2025). Tuttavia, la legge non prevede alcuna retribuzione né contribuzione durante questo periodo, né maturazione del TFR. Si tratta quindi di una tutela “a metà”: salva il posto, ma non il reddito.
Inoltre, viene introdotto un diritto prioritario allo smart working per chi fruisce del congedo lungo, purché compatibile con le mansioni e l’organizzazione aziendale (art. 5). Questa previsione, pur encomiabile sul piano dei principi, rischia di scontrarsi con la prassi aziendale, come già osservato da sindacati e studiosi.
La vera novità storica riguarda però i lavoratori autonomi e i professionisti. Per la prima volta, la legge riconosce loro un diritto alla sospensione dell’attività fino a 300 giorni all’anno in caso di patologie oncologiche o invalidanti. Durante tale periodo, la posizione previdenziale resta attiva, evitando l’interruzione dei contributi (art. 7, Legge 106/2025). Tale diritto è però subordinato a una condizione stringente: il lavoratore deve prestare attività in via continuativa per un committente. Restano quindi esclusi i professionisti con clientela frammentata o occasionale — una fetta consistente del mondo delle partite IVA.
La riforma dei caregiver familiari: promesse e delusioni
Parallelamente, la Legge di Bilancio 2026 (art. 53) istituisce un fondo per il riconoscimento del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni annui a decorrere dal 2027. L’obiettivo dichiarato è definire una figura giuridica nazionale del caregiver, riconoscendone il valore sociale ed economico.
Tuttavia, come denunciano le principali associazioni (Fish, Confad, Genitori Tosti), lo stanziamento per il 2026 è irrisorio rispetto ai bisogni reali. Basti pensare che il precedente fondo, soppresso nel 2024 e poi ripristinato, ammontava a 30 milioni. Il taglio radicale appare un affronto verso una platea stimata in quasi 8 milioni di persone, perlopiù donne over 40, che dedicano 24 ore su 24 all’assistenza di familiari non autosufficienti (Informazione Fiscale, 2025).
Il testo della Legge di Bilancio 2018 aveva già definito il caregiver familiare come colui che assiste un coniuge, convivente o parente entro il secondo grado (terzo in casi specifici) affetto da malattia cronica, degenerativa o disabilità grave, riconosciuto come non autosufficiente o titolare di indennità di accompagnamento. Ma senza una cornice normativa uniforme, le Regioni hanno applicato interventi disomogenei, creando un “welfare a macchia di leopardo”.
Giurisprudenza e diritto UE: la tutela antidiscriminatoria dei caregiver
Qui entra in gioco un aspetto cruciale: la tutela antidiscriminatoria riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tre sentenze fondamentali (C-356/19, C-357/19, C-447/20), la Corte ha affermato che il licenziamento di un lavoratore a causa del suo ruolo di caregiver può configurare una discriminazione indiretta basata sul sesso, in violazione della Direttiva 2006/54/CE.
In Italia, questa impostazione è stata recepita da pronunce come quella del Tribunale di Torino (16 settembre 2025), che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una dipendente che utilizzava in modo limitato i permessi per assistere un figlio disabile. La sentenza sottolinea che “l’esercizio del diritto all’assistenza familiare non può giustificare misure punitive da parte del datore di lavoro”.
Inoltre, la Rivista del Lavoro (2025) ricorda che il diritto UE impone agli Stati membri di garantire accomodamenti ragionevoli per i caregiver, soprattutto quando la loro condizione è legata a disabilità di un familiare. Questo principio, tuttavia, non trova ancora piena attuazione nel nostro ordinamento.
Criticità
Come osservatori del mondo del lavoro, non possiamo non rilevare una contraddizione stridente: da un lato, la Legge 106 introduce tutele innovative per autonomi e dipendenti, riconoscendo finalmente la vulnerabilità legata alla malattia; dall’altro, lo Stato sminuisce il ruolo dei caregiver familiari, negando loro un sostegno economico adeguato e differendo sine die una legge organica.
La Legge 106 è un passo avanti, ma non basta. Il congedo non retribuito per i dipendenti è una garanzia formale che, nella pratica, rischia di essere inutilizzabile per chi non ha risparmi. E per gli autonomi, la condizione di “continuità con un committente” esclude molti liberi professionisti, soprattutto donne che lavorano in settori frammentati (come la consulenza, l’educazione o le arti).
Quanto ai caregiver, la mancanza di una indennità strutturale, di crediti contributivi e di permessi retribuiti li condanna a una doppia invisibilità: sociale ed economica. Le sentenze della Corte UE e i principi costituzionali (art. 2, 3, 38 Cost.) impongono uno sforzo maggiore. Il welfare non può basarsi solo sulla buona volontà delle famiglie.
Conclusioni
La Legge 106/2025 merita riconoscimento per aver esteso le tutele ai lavoratori autonomi, una categoria storicamente abbandonata. Tuttavia, la sua efficacia sarà limitata finché non si affronterà il nodo della retribuzione durante il congedo e della copertura universale per tutti gli autonomi.
Parallelamente, la riforma dei caregiver non può ridursi a un annuncio contabile. I 207 milioni dal 2027 sono una base, ma vanno accompagnati da una legge quadro che definisca diritti, doveri, accesso ai servizi e riconoscimento previdenziale. Senza questo, il caregiver resterà un “eroe silenzioso”, costretto a scegliere tra dignità e reddito.
Il diritto del lavoro italiano ha l’occasione, nel 2026, di compiere una svolta umana e strutturale. Speriamo che il Parlamento e il Governo non la sprecchino.