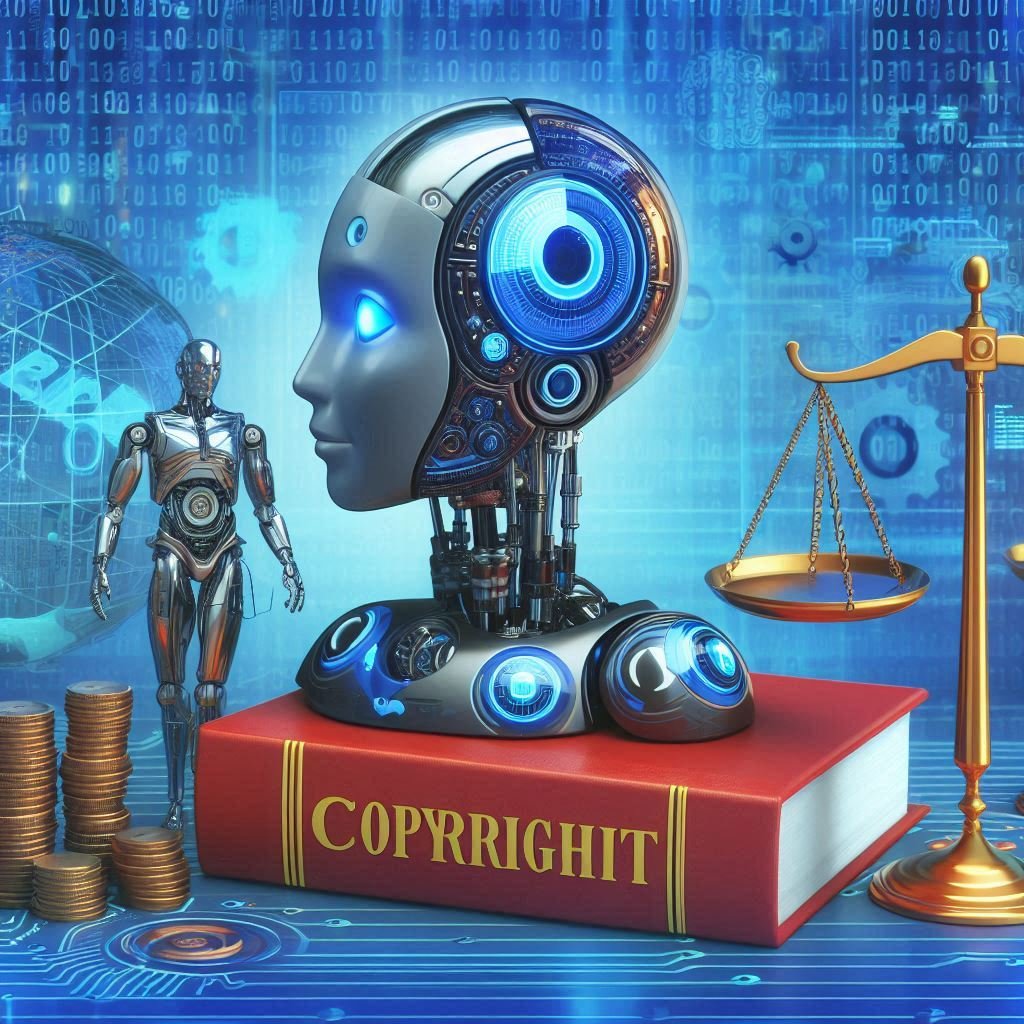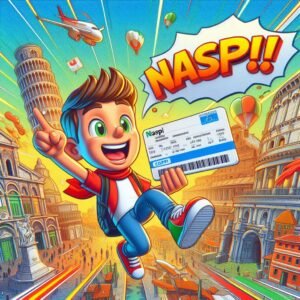Premessa: un crocevia normativo e culturale
L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) ha scosso le fondamenta del diritto d’autore, mettendo in crisi categorie giuridiche consolidate e sollevando interrogativi urgenti: chi è il titolare di un’opera generata da un algoritmo? È lecito addestrare un modello AI con opere protette senza autorizzazione? E, soprattutto, come tutelare gli autori in un contesto in cui la riproduzione e la rielaborazione diventano quasi istantanee?
A queste domande si stanno confrontando legislatori, giudici e operatori del settore. In Italia, il dibattito si è intensificato grazie a una serie di pronunce recenti – tra cui la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Battisti – e a iniziative istituzionali come quella del Ministero della Cultura e della SIAE, che hanno cercato di tracciare un percorso tra innovazione tecnologica e protezione dei diritti degli autori.
Il caso Battisti: quando il master non basta
Una delle sentenze più rilevanti degli ultimi mesi è l’ordinanza n. 12956 del 14 maggio 2025 della Corte di Cassazione nel contenzioso tra Sony Music e gli eredi di Lucio Battisti. La Suprema Corte ha ribadito con chiarezza un principio cardine del diritto d’autore italiano: la proprietà del supporto materiale (il master fonografico) non assorbe i diritti patrimoniali sull’opera musicale, che restano in capo all’autore o ai suoi eredi (artt. 12 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 – LDA). Sony sosteneva che, essendo proprietaria dei master originali, avesse il diritto di distribuire e sincronizzare le canzoni di Battisti anche dopo che gli eredi avevano revocato il mandato alla SIAE. La Cassazione ha respinto tale tesi, sottolineando che la revoca del mandato è un atto legittimo, previsto dallo Statuto SIAE e coerente con il principio di disponibilità dei diritti patrimoniali (art. 45 LDA). In assenza di un contratto che vincolasse gli eredi a concedere licenze in via continuativa, non poteva configurarsi né un illecito né un abuso. Questa pronuncia ha un valore paradigmatico: ricorda che la musica è un bene giuridico complesso, composto da due “anime” distinte – quella materiale e quella immateriale – e che ogni sfruttamento commerciale richiede autorizzazione esplicita da parte dei titolari dei diritti d’autore. Tale principio diventa ancora più rilevante nell’era dell’IA, dove la facilità di accesso e riproduzione digitale rischia di oscurare la necessità di un consenso legale.
L’IA generativa e il diritto d’autore: linee di frattura normative
Il Ministero della Cultura, con il comunicato del 27 marzo 2025, ha espresso preoccupazione per l’impatto della GenAI sul settore creativo, evidenziando il rischio di una “devalorizzazione” del lavoro umano e la necessità di riconoscere agli autori il controllo sull’uso delle loro opere nei processi di training. La SIAE, in linea con la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs), ha lanciato un appello globale affinché le opere siano escluse dai dataset di addestramento senza consenso esplicito. Tuttavia, il quadro giurisprudenziale internazionale è frammentato. Negli Stati Uniti, il Tribunale Distrettuale della California del Nord, con sentenza del 23 giugno 2025, ha ritenuto che l’uso di opere protette per il training di modelli linguistici rientri nel “fair use”, purché trasformativo. Ma ha anche chiarito che l’acquisizione di tali opere da fonti pirata è illegittima – un distinguo cruciale che mostra come nemmeno negli USA l’IA sia un “wild west” giuridico. In Europa, la sentenza Cofemel (C-683/17) della Corte di Giustizia ha già segnato una svolta: per essere protetto, un’opera deve essere originale, cioè riflettere le scelte libere e creative del suo autore. Non è richiesto un “valore artistico” oggettivo – requisito ancora presente nell’art. 2 n. 10 LDA italiano – il che crea una tensione tra diritto nazionale e diritto UE. La Cassazione, nella sentenza n. 11413/24 sul caso Castiglioni (lampada non tutelata perché parte di un allestimento), ha implicitamente riconosciuto questa incongruenza, auspicando un’interpretazione conforme al diritto comunitario.
Opere generate da IA: nessuna tutela senza intervento umano
La giurisprudenza è unanime nel negare la protezione del diritto d’autore alle opere generate esclusivamente da IA. La Corte d’Appello del Distretto di Columbia (USA) ha confermato che l’assenza di un autore umano esclude la sussistenza del copyright. In Italia, sebbene manchi una pronuncia esplicita, il principio è implicito nella LDA, che tutela le “opere dell’ingegno” (art. 1), concetto storicamente legato alla personalità umana. Ciò solleva un paradosso: un brano musicale creato da un algoritmo non è protetto, ma se un artista lo modifica in modo sostanziale – aggiungendo armonie, testo, arrangiamento – l’opera risultante può beneficiare di tutela, purché l’apporto umano sia originale. È il caso di molte produzioni odierne, dove l’IA è uno strumento, non un autore.
La responsabilità del “contatto sociale” non colma i vuoti contrattuali
Un aspetto spesso trascurato è il tentativo di alcune imprese (come Sony nel caso Battisti) di invocare la responsabilità da “contatto sociale” per obbligare i titolari di diritti a negoziare. La Cassazione ha però chiarito che tale figura non si applica automaticamente: occorre una violazione di una regola di condotta specifica imposta dalla legge, non un generico dovere di collaborazione. Questo principio è fondamentale per evitare che la giurisprudenza supplisca a carenze contrattuali, soprattutto in settori dinamici come quello digitale.
Una proposta: equilibrio tra innovazione e giustizia creativa
Dopo aver analizzato le fonti – dalla SIAE al Ministero della Cultura, dalle sentenze italiane a quelle europee e statunitensi – ritengo che l’Italia debba riformare la LDA alla luce della giurisprudenza UE, eliminando il requisito del “valore artistico” per le opere di design e allineando la nozione di originalità a quella comunitaria. Inoltre, è urgente una disciplina specifica per il training di modelli AI: non si può permettere che miliardi di opere siano “saccheggiate” da dataset senza consenso, come denunciato dalla SIAE in relazione al rischio di perdite per 22 miliardi di euro nei prossimi anni. Al contempo, occorre evitare divieti assoluti che soffochino l’innovazione. Una soluzione potrebbe essere un meccanismo di opt-out chiaro e accessibile, accompagnato da un sistema di remunerazione collettiva gestito da enti come la SIAE, simile a quanto previsto per la copia privata. Infine, bisogna educare il mercato: artisti, editori, piattaforme devono comprendere che la proprietà del file non è la proprietà del diritto. Il caso Battisti lo ha insegnato con chiarezza. Nell’era dell’IA, questa lezione diventa ancora più vitale.
Conclusione
L’intelligenza artificiale non è un nemico della creatività, ma neppure un’area franca dal diritto. La tutela degli autori non è un freno all’innovazione, ma il suo fondamento etico e giuridico. Come ha ricordato la Cassazione, i diritti d’autore sono disponibili, ma non negoziabili in silenzio. Spetta al legislatore, con coraggio e competenza, tracciare un nuovo equilibrio – perché la musica, il design, la letteratura non diventino meri dati da elaborare, ma restino espressioni irriducibili della persona umana.