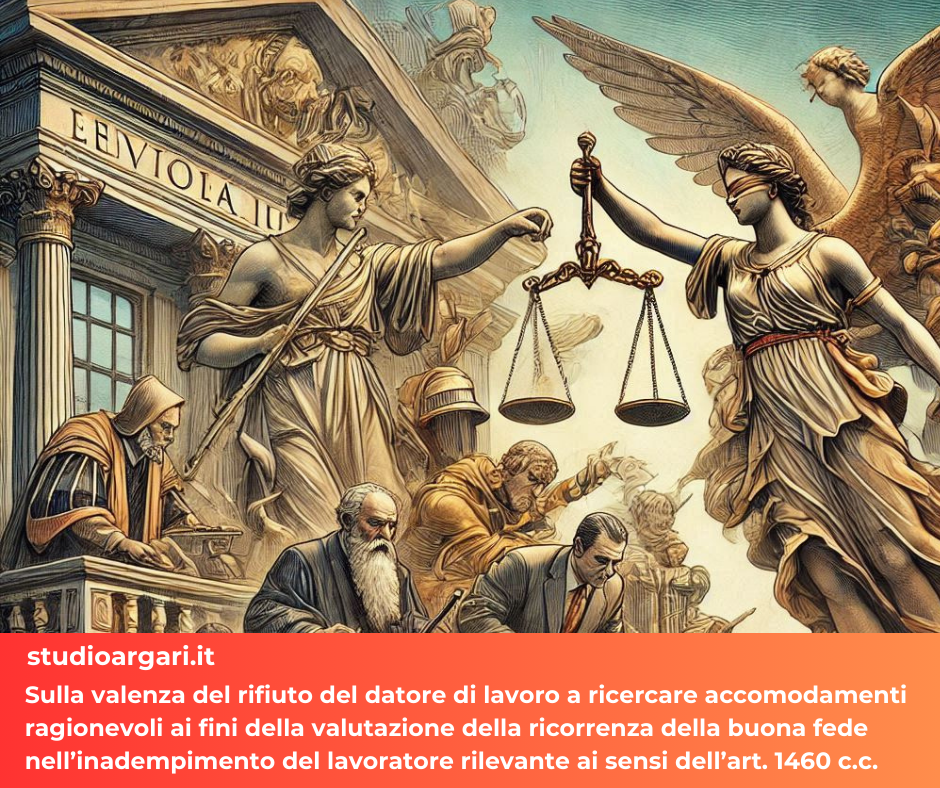La giurisprudenza sui ragionevoli accomodamenti continua a delineare in modo sempre più preciso questa fattispecie, contribuendo così a ridurre l’indeterminatezza della sua definizione. Questo concetto è stato introdotto nel nostro ordinamento solo dopo che l’Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per il mancato corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE, in particolare riguardo all’obbligo di prevedere tali accomodamenti (CGUE, 4 luglio 2013, C-312/11, Commissione Europea contro Repubblica Italiana). La condanna ha portato all’inserimento del comma 3-bis nell’articolo 3 del d.lgs. n. 216/2003.
L’impianto normativo originario presentava limiti evidenti: da un lato, una definizione degli accomodamenti ragionevoli troppo generica; dall’altro, l’assenza di procedure chiare per la richiesta e l’implementazione di tali misure.
Con il d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62, nozioni e procedure sono state recentemente riviste e meglio articolate. Tuttavia, è la Corte di Cassazione, attraverso la sua funzione nomofilattica, a svolgere un ruolo essenziale nello sviluppo e nella chiarificazione dei relativi concetti, spesso colmando le lacune normative ancora presenti.
Con questa pronuncia, la Suprema Corte ribadisce con estrema chiarezza e, si potrebbe dire, in modo definitivo, i limiti entro cui il concetto di ragionevoli accomodamenti obbliga il datore di lavoro ad adottare misure concrete per eliminare o ridurre al minimo le barriere che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita professionale, garantendo parità con gli altri lavoratori.
Per quanto riguarda il caso specifico, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato la legittimità del licenziamento.
Il licenziamento era stato deciso a causa della reiterata assenza ingiustificata dal luogo di lavoro assegnato, situato a centinaia di chilometri dal domicilio del lavoratore. La Corte ha stabilito che, anche se il lavoratore, affetto da una patologia oncologica, riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap grave, avesse diritto all’assegnazione presso una sede più vicina alla sua residenza rispetto a quella originaria, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l’eccezione di inadempimento invocata per giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa. Questo giudizio è rimasto valido nonostante nel frattempo si fosse effettivamente reso disponibile un posto di lavoro più vicino alla sua abitazione.
Secondo la Corte d’appello, indipendentemente dalla valutazione sull’eventuale possibilità che la società potesse adottare accomodamenti ragionevoli per un migliore impiego del lavoratore considerando le sue patologie e limitazioni, non risulta dimostrato – ma solo genericamente indicato – che le condizioni di salute dell’interessato gli impedissero di riprendere il lavoro presso la sede assegnata prima dell’insorgere della malattia. Tuttavia, tale argomentazione viene duramente contestata dalla Cassazione, che la ritiene non conforme al quadro normativo di speciale tutela previsto sia dall’ordinamento interno che da quello comunitario per le persone con disabilità.
In particolare, l’articolo 2 della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità definisce discriminazione basata sulla disabilità qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione fondata su tale condizione che abbia lo scopo o l’effetto di compromettere o annullare, su base di uguaglianza con gli altri, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro ambito. La stessa definizione include ogni forma di discriminazione, incluso il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole. Per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non comportino un onere sproporzionato o eccessivo, da attuare ove necessario in casi particolari per garantire alle persone con disabilità l’accesso paritario a diritti e libertà fondamentali.
A livello comunitario, la direttiva 2000/78/CE, nell’articolo 5 dedicato alle soluzioni ragionevoli per i disabili, sancisce che per rispettare il principio di parità di trattamento, è necessario prevedere soluzioni adeguate. Tali soluzioni richiedono che il datore di lavoro adotti provvedimenti appropriati in base alle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere al lavoro, svolgerlo, ottenere una promozione o ricevere una formazione. Questo obbligo esclude i casi in cui tali misure comportino un onere finanziario sproporzionato per il datore di lavoro.
Premesso ciò, la Corte di Cassazione, accogliendo uno specifico motivo di ricorso, ha rilevato che, nell’applicare l’art. 1460, secondo comma, c.c., secondo cui il lavoratore può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione solo quando tale rifiuto, valutato alla luce delle circostanze del caso concreto, non sia contrario ai principi di buona fede, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare adeguatamente l’entità dell’inadempimento del datore di lavoro. Questo parametro deve essere esaminato in relazione al complessivo equilibrio di interessi regolati dal contratto e alla concreta incidenza dell’inadempimento datoriale su esigenze fondamentali, sia personali sia familiari, del lavoratore. A tal proposito, la Suprema Corte rimanda a precedenti sentenze sul tema, come Cass. 4404/2022 e Cass. 11408/2018.
La Corte d’Appello, dunque, ha errato nel trascurare la rilevanza dell’obbligo di prevedere accomodamenti ragionevoli in capo al datore di lavoro nei confronti di un dipendente disabile. La Cassazione sottolinea con fermezza che il rifiuto di offrire tali accomodamenti costituisce atto discriminatorio e, in quanto tale, è nullo. Tale nullità non può in alcun modo avvantaggiare il datore di lavoro. Solo all’interno di questo quadro normativo la Corte bolognese avrebbe dovuto analizzare il peso dell’inadempimento dell’azienda e verificare se il rifiuto del dipendente fosse o meno contrario a buona fede.
A giudizio di chi scrive, la Suprema Corte ha colto l’essenza della condotta irregolare del datore di lavoro in questo caso specifico. Si tratta di una grave violazione, che consiste nel disattendere un diritto sancito sia dalla normativa nazionale che da quella sovranazionale, utilizzando consapevolmente tale omissione per giustificare un licenziamento.
Con questa pronuncia, che si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, la Cassazione sembra voler porre un freno alla superficialità con cui alcuni datori di lavoro—specialmente quelli di grandi dimensioni—tendono a ignorare obblighi imposti da norme sovranazionali. Norme che, evidentemente, non risultano ancora pienamente recepite dall’ordinamento giuridico interno.
Spetterà ora alla Corte d’Appello di Firenze, quale giudice del rinvio, riesaminare il caso alla luce dei principi richiamati. In particolare, sarà necessario effettuare una valutazione più aderente al quadro normativo nazionale ed eurounitario, prendendo correttamente in considerazione il confronto tra le reciproche inadempienze ignorato dalla precedente sentenza felsinea.