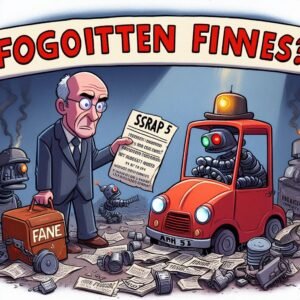In un contesto di crescente incertezza sociale ed economica, segnato da inflazione persistente, frammentazione del mercato del lavoro e paralisi politica sul tema del salario minimo, la Corte di Cassazione ha assunto un ruolo inedito: non più semplice interprete delle norme, ma custode attivo dei diritti fondamentali del lavoratore. Con due sentenze quasi gemelle – la n. 28230/2023 e la n. 27711/2023 – i giudici di legittimità hanno tracciato una linea di demarcazione netta tra la contrattazione collettiva e i principi costituzionali, riaffermando con forza che nessun accordo, neppure un contratto collettivo nazionale (CCNL), può derogare all’articolo 36 della Costituzione.
Questo articolo, spesso citato ma raramente applicato in modo concreto, sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e, soprattutto, sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Fino a oggi, tale principio era stato considerato una sorta di “bussola ideale”, il cui contenuto veniva affidato in via esclusiva alla contrattazione tra parti sociali. Si presumeva, infatti, che i CCNL, frutto del confronto tra sindacati e datori di lavoro, fossero di per sé conformi ai dettami costituzionali. La Cassazione, invece, ha ribaltato questa prospettiva: la conformità non è più presunta, ma soggetta a verifica giudiziale.
La fine della presunzione di legittimità dei CCNL
La svolta è contenuta in modo esplicito nella sentenza n. 27711/2023, al punto 32, dove si legge:
«Nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione».
Questa affermazione ha conseguenze di portata storica. Significa che il giudice, di fronte a una retribuzione formalmente legittimata da un CCNL, può disapplicare parzialmente quel contratto se ritiene che la paga effettiva non garantisca una vita dignitosa. Non si tratta di annullare il sistema della contrattazione collettiva – che resta fondamentale – ma di subordinarne l’efficacia al rispetto dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall’articolo 2 della Costituzione.
erché ora? Il fallimento della contrattazione “reale”
La Corte non agisce nel vuoto. Le sentenze contengono una lucida diagnosi del sistema attuale delle relazioni industriali, descritto come afflitto da mali strutturali:
- la frammentazione sindacale, con decine di sigle spesso prive di reale rappresentatività;
- la proliferazione di “contratti pirata”, stipulati per eludere tutele e abbassare artificialmente i costi del lavoro;
- l’esistenza di oltre 900 CCNL solo nel settore privato, una giungla normativa che genera incertezza e disuguaglianze;
- la disparità salariale tra lavoratori con identiche mansioni, a seconda del contratto applicato;
- l’erosione inflazionistica degli stipendi, aggravata dai ritardi nei rinnovi contrattuali.
In questo scenario, la contrattazione collettiva non sempre assolve alla sua funzione costituzionale di garanzia. Anzi, in alcuni casi, diventa uno strumento di legittimazione del “lavoro povero”. Di fronte a tale fallimento, la Cassazione sceglie di intervenire, non per sostituirsi alle parti sociali, ma per ripristinare l’equilibrio tra libertà contrattuale e diritti fondamentali.
Quali strumenti ha il giudice?
Il magistrato non è lasciato senza bussola. Le sentenze indicano con chiarezza le opzioni a sua disposizione quando un CCNL risulta inadeguato:
- Scegliere un altro CCNL come parametro di riferimento, anche se non applicato in azienda, purché sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- Ricorrere a parametri esterni, come la soglia di povertà relativa calcolata dall’ISTAT, o – con le opportune cautele – gli importi degli ammortizzatori sociali (NASPI, CIG), considerati indicatori minimi di sussistenza.
- Valutare la retribuzione in un’ottica olistica, tenendo conto non solo dei bisogni materiali (alloggio, cibo, salute), ma anche dell’accesso a beni immateriali, come l’istruzione, la cultura e la partecipazione sociale – un concetto esplicitamente richiamato dal Considerando n. 28 della Direttiva UE 2022/2041 sui salari minimi adeguati.
Sebbene le sentenze nascano da controversie nel settore delle cooperative (disciplinato dalla Legge n. 142/1990), la Corte estende esplicitamente il principio a:
- il Terzo Settore (art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017);
- i contratti pubblici di appalto, dove l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti) impone l’applicazione dei CCNL di settore.
Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante: anche nelle gare pubbliche, dove la legge impone l’osservanza di un CCNL specifico, il giudice potrà intervenire se quella retribuzione, pur “legale”, risulterà costituzionalmente insufficiente. Si apre così la strada a un contenzioso potenzialmente vastissimo, che potrebbe ridisegnare interi settori del mercato del lavoro.
Una rivoluzione silenziosa, non una tempesta
Contrariamente a chi vede in queste sentenze un attacco alla contrattazione collettiva, si tratta piuttosto di un richiamo all’ordine costituzionale. Non viene introdotto un salario minimo legale, né viene abolito il ruolo dei sindacati. Viene semplicemente ribadito che la Costituzione è la fonte primaria del diritto del lavoro, e che nessun accordo – per quanto formalmente legittimo – può violarne i principi fondamentali.
In un momento in cui la politica fatica a trovare una soluzione condivisa sul salario minimo, la Cassazione ha scelto di non attendere. Ha dato ai lavoratori uno strumento potente: il diritto di chiedere al giudice non solo di applicare la legge, ma di difendere la loro dignità umana attraverso la retribuzione. E in questo, non c’è sensazionalismo: c’è solo il coraggio di applicare la Costituzione, parola per parola.