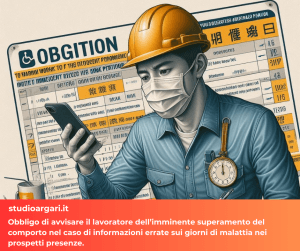L’articolo analizza la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, con particolare attenzione al nuovo orientamento che considera il “rischio di caduta” come elemento sufficiente a configurare l’impossibilità di deambulare senza pericolo, equiparandolo di fatto all’immobilità ai fini del diritto all’accompagnamento.
Introduzione
Il diritto all’indennità di accompagnamento rappresenta uno dei pilastri della tutela sociale a favore delle persone con gravi disabilità. Disciplinato dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, tale beneficio è riconosciuto a coloro che, a causa di menomazioni permanenti, si trovino nell’“impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “necessitino di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Per decenni, l’interpretazione di questa norma è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, con una tendenza spesso restrittiva da parte delle commissioni mediche e dei giudici di merito. Tuttavia, negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha avviato una vera e propria “rivoluzione ermeneutica”, ampliando il concetto di “impossibilità di deambulare” fino a includere non solo l’assoluta incapacità motoria, ma anche situazioni in cui il soggetto, pur camminando, corre un rischio concreto e grave di caduta.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione
La svolta interpretativa è emersa con chiarezza in una serie di pronunce, tra cui la sentenza n. 25033 del 2023, richiamata anche nell’articolo de La Legge per Tutti. In tale decisione, la Suprema Corte ha affermato che il rischio di caduta, se oggettivamente documentato e clinicamente rilevante, deve essere considerato equivalente all’immobilità ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
In particolare, la Corte ha chiarito che:
“L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 18/1980, va intesa non solo nel senso dell’assoluta incapacità di muoversi, ma anche nel senso dell’impossibilità di camminare in sicurezza, ovvero in presenza di un rischio concreto e grave di caduta che renda necessaria la presenza costante di un accompagnatore per prevenire danni alla persona.”
Questa affermazione segna un cambio di paradigma: non è più rilevante solo la capacità fisica di muoversi, ma anche la sicurezza con cui tale movimento può essere compiuto. Si tratta di un approccio più umano, coerente con i principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità della persona (art. 2 Cost.), nonché con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009.
Le conseguenze pratiche per i cittadini
Questa evoluzione giurisprudenziale ha un impatto diretto su migliaia di cittadini affetti da patologie neurologiche, ortopediche o cardiocircolatorie che, pur non essendo completamente allettati, presentano una grave instabilità posturale. Si pensi, ad esempio, a pazienti con Parkinson avanzato, sclerosi multipla, gravi forme di artrosi, deficit vestibolari cronici o postumi di ictus.
In passato, tali soggetti venivano spesso esclusi dal beneficio perché “tecnicamente capaci di camminare”, anche se con estrema difficoltà e pericolo. Oggi, grazie alla nuova interpretazione, possono legittimamente richiedere – o richiedere nuovamente – il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, a condizione che la documentazione clinica dimostri in modo chiaro e specifico il rischio di caduta.
A tal proposito, è fondamentale che le relazioni mediche non si limitino a descrivere genericamente la patologia, ma specifichino con precisione:
- la frequenza e la gravità degli episodi di caduta o di quasi-caduta;
- la presenza di vertigini, svenimenti, perdita di equilibrio;
- la necessità di ausili (bastone, deambulatore, sedia a rotelle);
- la dipendenza da terzi per gli spostamenti esterni o anche interni all’abitazione.
Il ruolo delle commissioni mediche e dei giudici
La nuova giurisprudenza della Cassazione impone un ripensamento anche alle commissioni mediche dell’INPS. Queste, infatti, dovranno valutare non solo la capacità motoria “in astratto”, ma anche il contesto funzionale reale del paziente. Non basta più chiedere “cammina o no?”, ma occorre domandarsi: “cammina in sicurezza?”.
In caso di diniego, il ricorso al giudice ordinario (Tribunale in funzione di giudice del lavoro) rimane lo strumento principale per ottenere il riconoscimento del diritto. La Cassazione, con le sue sentenze più recenti, ha fornito ai giudici di merito un criterio chiaro e vincolante: la sicurezza nella deambulazione è parte integrante della capacità di camminare.
Conclusioni
L’evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione rappresenta un passo avanti fondamentale verso una concezione più inclusiva e realistica della disabilità. Riconoscere il rischio di caduta come equivalente all’immobilità significa porre al centro la persona, con le sue fragilità concrete, e non un mero parametro burocratico.
Per i cittadini, ciò si traduce in una maggiore possibilità di accesso a un diritto fondamentale. Per gli operatori del diritto e i professionisti sanitari, richiede un approccio più attento, documentato e sensibile alle esigenze reali dei pazienti.
In un’epoca in cui l’invecchiamento della popolazione e la complessità delle patologie croniche sono in costante aumento, questa “rivoluzione della Cassazione” non è solo un’evoluzione giuridica, ma una necessità sociale ed etica.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati:
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1
- Costituzione italiana, artt. 2 e 32
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 25033 del 2023
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 14218 del 2022
- INPS – Messaggio n. 1890 del 2023 (orientamenti applicativi)