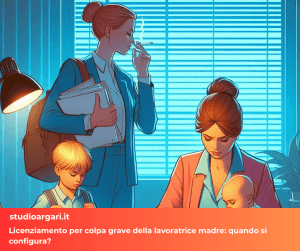La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha stabilito che lo smart working può costituire un “accomodamento ragionevole” ai sensi della Direttiva 2000/78/CE e dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, quando risulti idoneo a garantire al lavoratore con disabilità il mantenimento del posto di lavoro senza imporre al datore oneri sproporzionati. Il rifiuto di adottare tale misura, in caso di accertata disabilità, può integrare un illecito discriminatorio e rendere illegittimo un eventuale licenziamento o trasferimento.
1. Premessa: il contesto normativo e giurisprudenziale
Nel sistema giuridico italiano – come in quello dell’Unione Europea – la tutela delle persone con disabilità non si limita a un generico appello all’uguaglianza, ma si concretizza in specifici obblighi per il datore di lavoro. Tra questi, assume un ruolo centrale il principio degli “accomodamenti ragionevoli”, introdotto in Italia con il recepimento della Direttiva n. 2000/78/CE attraverso il decreto legislativo n. 216/2003.
L’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. 216/2003 stabilisce che:
“Si intendono come discriminazioni anche il rifiuto di adottare misure appropriate e specifiche destinate a consentire la piena partecipazione alla vita professionale delle persone con disabilità, a meno che tali misure impongano al datore di lavoro un onere sproporzionato o eccessivo”.
Questa norma impone dunque un dovere attivo al datore: non basta astenersi dal discriminare, ma occorre intervenire attivamente per rimuovere ostacoli legati alla disabilità, purché ciò non comporti costi o sforzi insostenibili per l’azienda.
2. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
Nell’ordinanza Cassazione civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2025, n. 605, la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi su un caso in cui un lavoratore con una condizione psico-fisica invalidante si era visto proposto un trasferimento aziendale. A causa della sua disabilità, il trasferimento avrebbe comportato gravi disagi, rendendo difficoltoso – se non impossibile – il mantenimento della prestazione lavorativa. Il lavoratore ha rifiutato il trasferimento, e il datore ha proceduto al licenziamento. La questione centrale è se tale licenziamento sia lecito o se – al contrario – il datore avesse l’obbligo di cercare una soluzione alternativa, ad esempio consentendo lo smart working dall’abitazione.
3. La nozione di disabilità secondo il diritto eurounitario
La Corte richiama la nozione eurounitaria di disabilità, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tale nozione non si limita alle menomazioni fisiche o sensoriali visibili, ma comprende anche condizioni patologiche di lunga durata che limitano la capacità di partecipare pienamente alla vita lavorativa. In questo senso, la disabilità non è solo una questione medica, ma una barriera sociale ed organizzativa: se l’ambiente di lavoro non è adattato alle caratteristiche della persona, questa viene esclusa ingiustamente.
4. Lo smart working come “accomodamento ragionevole”
Ecco il passaggio cruciale dell’ordinanza. La Corte afferma che:
“Il ragionevole accomodamento organizzativo può essere individuato nella soluzione dello smart working dall’abitazione allorché, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, risulta idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa”.
Questa affermazione è di grande rilievo, perché eleva lo smart working a strumento di inclusione lavorativa, non più solo come flessibilità organizzativa generica, ma come misura di pari opportunità per i lavoratori con disabilità.
La Corte non dice che lo smart working debba essere concesso automaticamente a tutti, ma stabilisce due condizioni fondamentali:
- Idoneità: deve essere effettivamente utile per permettere al lavoratore con disabilità di svolgere il proprio ruolo;
- Proporzionalità: non deve comportare “oneri sproporzionati” per l’azienda.
Se queste condizioni sono soddisfatte, il datore ha l’obbligo giuridico di adottarlo. Il mancato adempimento configura una discriminazione indiretta, sanzionata dal diritto antidiscriminatorio.
5. L’onere della prova e il ruolo del giudice
Un aspetto innovativo riguarda anche il regime probatorio. In caso di presunta discriminazione, il lavoratore ha un onere della prova “agevolato”: basta fornire elementi indiziali sufficienti a far sospettare una condotta discriminatoria. A quel punto, l’onere si sposta sul datore, che deve dimostrare di aver adottato tutti gli accomodamenti ragionevoli possibili o che questi avrebbero comportato un onere sproporzionato. Inoltre, la Corte sottolinea che il giudice di merito può individuare autonomamente soluzioni di accomodamento, anche in assenza di accordo tra le parti. Ciò significa che il giudice non deve limitarsi a sanzionare il comportamento illecito, ma può suggerire – o imporre – misure concrete per ripristinare la parità di trattamento.
6. La “vis espansiva” della tutela antidiscriminatoria
L’ordinanza si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza, che tende a espandere la tutela antidiscriminatoria in ogni fase del rapporto di lavoro: assunzione, mansioni, trasferimenti, licenziamenti. In particolare, la Corte afferma che l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli condiziona “a monte il potere di recesso del datore”. In altre parole: non si può licenziare un lavoratore con disabilità senza aver prima valutato – seriamente e in buona fede – se esista una soluzione alternativa per mantenerlo in servizio, anche con modalità organizzative diverse. Questo principio ribalta la prospettiva tradizionale: il posto di lavoro non è solo un contratto da eseguire, ma un diritto da preservare, soprattutto per chi è più vulnerabile.
7. Una svolta culturale e giuridica
L’ordinanza della Cassazione n. 605/2025 rappresenta una svolta significativa nella tutela dei lavoratori con disabilità. Riconoscendo lo smart working come possibile accomodamento ragionevole, la Corte non solo recepisce in modo fedele la Direttiva europea, ma promuove una visione inclusiva del lavoro, basata sulla personalizzazione della prestazione piuttosto che sull’adattamento forzato del lavoratore a modelli rigidi.In un’epoca in cui il lavoro agile è ormai diffuso, questa decisione ne valorizza una funzione sociale spesso sottovalutata: non è solo strumento di produttività o di conciliazione vita-lavoro, ma può essere – e in alcuni casi deve essere – un diritto di cittadinanza lavorativa per chi altrimenti sarebbe escluso.Infine, la pronuncia invita datori di lavoro, consulenti e giudici a un atteggiamento proattivo: non aspettare che il problema si presenti in forma drammatica (licenziamento, malattia, abbandono), ma intervenire preventivamente con intelligenza organizzativa, empatia e rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale (art. 1375 c.c.), nonché del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ormai strettamente connesso alla tutela della salute psico-fisica.